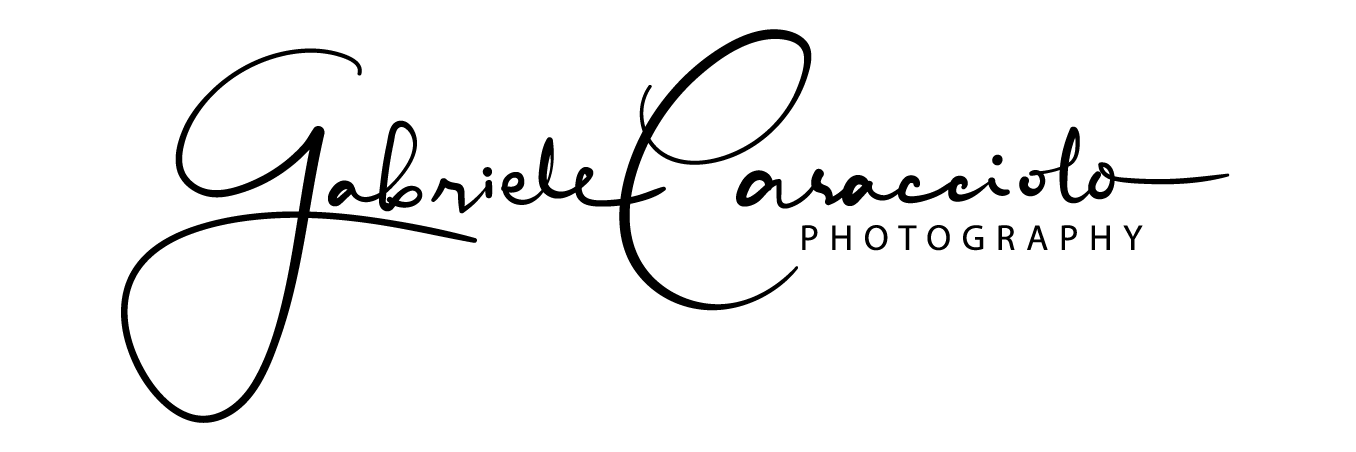Appunti di fotografia [145] – Franco Zecchin
Gli appunti che seguono sono stati presi durante l’incontro della FIAF dell’11.1.24 dedicato a Franco Zecchin. Vi consiglio caldamente la sua visione integrale a questo indirizzo: https://youtu.be/7GSlYDToq3U. Il titoli dei paragrafi li ho messi io in base a ciò che volevo evidenziare/ricordare.
Giovanna Calvenzi introduce Franco Zecchin, leggendo ciò che Letizia Battaglia ha detto di Franco riguardo il suo inizio professionale a Palermo.
Franco Zecchin per Letizia Battaglia
“Franco per un po’ è stato a guardare, poi piano piano ha cominciato a prendere in mano la macchina fotografica, ha messo ordine nell’organizzazione del lavoro, ha cominciato a fare i provini, a schedare le foto che facevamo. E’ stato subito evidente che era un bravo fotografo, che aveva talento. E’ di quei fotografi che non ti accorgi che esistono, essenzialmente è invisibile. Mentre io bisticciavo con i poliziotti lui scattava. Quando lavoravamo insieme, io guardavo e mi chiedevo – ma perché non scatta? – e lui aveva già scattato più di me. Senza parole, riservato. Io facevo casino, lui faceva belle foto. La cosa interessante è che quando tornavamo in studio, sviluppavamo, facevamo i provini, sapevamo subito cosa scegliere, senza rivalità, sicuramente ha fatto foto molto più belle delle mie. Non sbagliava mai, aveva una sorta di freddezza, di non partecipazione apparente a quanto succedeva, credo che dipendesse dal fatto che io sono di questa terra e Franco è milanese e si sentiva tra virgolette osservatore “.
La sua formazione e il suo lavoro al giornale
Franco Zecchin parlando del suo lavoro e del giornale in cui lavorava: “era un giornale del pomeriggio, quindi che dava molto spazio alle fotografie, quindi aveva bisogno di avere fotografie, anzi, sulla richiesta di queste cose in più noi potevamo proporre delle altre immagini che avevamo fatto noi a prescindere (dalle richieste), in modo anche così, autonomo, indipendente, che se la redazione giudicava interessanti, le pubblicava pure come è successo diverse volte. Per me è stata una scuola di giornalismo e di fotogiornalismo fatta diciamo nella pratica. Non avevo nessun tipo di formazione su come si fa giornalismo, su come si fa fotografia in questi casi. Me la sono costruita piano piano con l’esperienza. Intanto eravamo un gruppo di fotografi, con Letizia e con gli altri fotografi ci scambiavamo le impressioni, i consigli, i giudizi, rispetto al lavoro che facevamo, cercavamo anche, in qualche modo di… già dall’inizio c’era una passione per la fotografia che andava al di là di quella che poteva essere l’esigenza di qualità fotografica che era richiesta o accettata dal giornale di allora. Quindi noi cercavamo anche altri riferimenti che non erano solo quelli locali, tant’è che ogni anno andavamo al festival di fotografia di Arles per incontrare fotografi sia italiani che non avevamo la possibilità di incontrare stando a Palermo ma anche stranieri, francesi, americani, insomma, era un punto di incontro. Potevamo vedere mostre, lavori di altro tipo. E poi c’era questa apertura, questo interesse. mi ricordo che eravamo abbonati alla rivista Camera, quella svizzera che era mensile. Ogni mese ci arrivava e c’era questa finestra sul mondo della fotografia internazionale. All’epoca non esisteva ovviamente il web, quindi… in più eravamo a Palermo, non è che ci fossero molte altre possibilità di conoscere. Tant’è che abbiamo aperto insieme a Letizia il primo centro di fotografia… con una galleria fotografica e una libreria specializzata dove venivano poi fotografi a esporre e anche a vedere, a guardare… un’iniziativa di promozione culturale della fotografia a Palermo e in Sicilia. “
Lavorare INSIEME, in GRUPPO
Alla domanda “Che cosa significava lavorare insieme allora? Oggi l’idea del fotografo come una specie di cowboy solitario, prevale, mentre mi sembra che allora ci fosse più un’idea di un lavoro collettivo che fra l’altro non riguardava soltanto voi di quella particolare situazione ma era proprio anche di altri fotografi di altri ambiti anche molto diversi… Voglio dire, perché i fotografi non erano così gelosi uno dell’altro, perché si pensava che la fotografia fosse qualcosa che si poteva fare insieme?”
Franco risponde: “Diciamo che il fatto di lavorare in gruppo prioritariamente era in qualche modo una risposta a delle esigenze particolari per cui spesso essere in due, alle volte eravamo anche in tre sulla stessa scena, alle volte eravamo anche di più, perché dipende se è una cosa già programmata tipo un funerale… c’è quello che fa le prime fotografie e poi deve correre in redazione per svilupparle, quello che rimane perché poi magari c’è qualcosa che si sviluppa in seguito… c’è una distribuzione temporale e spaziale anche, perché spesso chi è da un lato non può essere nello stesso momento dall’altro e le cose possono succedere in due posti diversi nello stesso momento… E’ anche una questione di logistica, di riuscire a coprire meglio l’avvenimento che dovevamo fotografare.
Poi, al di là di questa esigenza più tecnica, c’era anche l’idea che in fondo perseguivamo insieme lo stesso obiettivo, quello di disporre di un materiale fotografico che usciva da questo gruppo di una qualità migliore possibile. Quindi ci spalleggiavamo l’un l’altro per cercare poi di ottenere un qualche cosa… cioè non c’era l’idea: questa foto è mia, questa foto è tua… io sono più bravo… Questo soprattutto con Letizia. Tant’è che per esempio nel volume Chroniques Siciliennes, all’epoca noi firmavamo le foto: foto di Letizia Battaglia e Franco Zecchin, senza distinguere di chi erano. […]”
La differenza dell’APPROCCIO di Letizia Battaglia e Franco Zecchin
Franco dice: “L’approccio di Letizia era più un approccio direi performativo. Letizia arriva e afferma la sua presenza con la macchina fotografica. Io sono qua, provoco con il mio esserci una reazione e attraverso la reazione che ho provocato, colgo l’essenzialità del fatto con cui sono in rapporto.
Per me era assolutamente il contrario, nel senso che io non volevo provocare nulla, volevo giustamente… attenuare, sminuire la mia presenza, cosa che tutt’ora fa parte del mio modo di fotografare, per poter reagire in modo più trasparente possibile alle sollecitazioni che mi arrivavano. Ovviamente poi c’è sempre un’interpretazione anche da parte mia. Però in questo caso Letizia nella testimonianza che ha citato Giovanna lo descrive come il milanese freddo e distante, perché lei invece siciliana è calda e passionale… E’ un modo un po’ stereotipato di vedere la cosa… Io pure partecipavo, però era un modo diverso di partecipare.
Giovanna Calvenzi interviene dicendo: “Io ho sempre davvero guardato il lavoro di Letizia e tuo, e quest’idea di complementarietà, per me invece era chiarissimo, perché lei dice ridendo che tu eri freddo e milanese e lei era calda e palermitana, ma è evidente che è una boutade… io Letizia l’ho vista al lavoro. Letizia era dirompente. Quindi dava spazio a chi voleva riflettere, interpretare, guardare, perché tanto lei stava facendo la protagonista della situazione e ci sono alcune immagini… dove io ricordo che c’era anche lei…le foto delle famiglie per esempio, e si vede benissimo che lei sta andando proprio addosso, come dire, a questa famiglia, e tu hai un passo… ma non è questione di freddezza, è questione di approccio visivo diverso… tu sei più meditativo e la tua immagine ha una composizione… le ho guardate tutte più volte… non ce n’è una che ha la composizione sbagliata, non so come dirti, tu hai messo nell’immagine esattamente quello che volevi metterci. Cioè l’hai creata tu questa situazione… e lo puoi fare perché tu sei uno che guarda, che sta attento e che aspetta.
Noi abbiamo fatto già in passato delle riflessioni… tra le differenze nel modo di lavorare tra William Klein e Henri Cartier-Bresson. William Klein doveva entrare nella situazione, esserci, modificarla, far vedere che lui c’era. Cartier-Bresson doveva sparire. E io ho sempre un po’, con margini ovviamente diversi, pensato al vostro lavoro un po’ in questa direzione. Una che va nella situazione e uno che resta ai margini ma che la racconta con grande classe.“
La fotografia per Franco Zecchin
Gli viene detto “tu sei sicuramente quello che gli americani potrebbero chiamare un fotografo concerned, direi, impegnato. Giri il mondo, fai lavori diversi ma quello che ti interessa maggiormente è l’aspetto sociale ma anche antropologico dei luoghi che frequenti, vai anche a scoprire quali sono le criticità, quelli che sono i problemi che nei vari luoghi in cui vai a fotografare emergono, no? Mi sembra che questa sia un po’ una delle tue caratteristiche… non sei uno spettatore neutro ma cerchi di entrare nello spirito delle popolazioni, dei luoghi… per testimoniare un qualche cosa nei loro confronti”.
Franco risponde: “Intanto l’idea di spettatore neutro non corrisponde a una realtà, non esiste uno spettatore neutro, qualsiasi sguardo seleziona e quindi fa un’operazione in qualche modo che non è neutrale. Quello che per me è importante in tutto questo è l’onesta. Cioè, io non voglio aggiungere più di tanto… l’operazione che faccio io è quella di togliere, di essenzializzare in un certo senso, di togliere tutto quello che disturba, che crea rumore, che non collabora a una coreografia d’insieme. Per cui in fondo anche in questo sottrarre, in questo selezionare, ovviamente c’è un’operazione autoriale. Intervengo, c’è un mio sguardo, c’è una mia interpretazione. In fondo per me, quello che mi piace nella fotografia, è perché ho un modo di entrare in relazione con il mondo. E in questo… poi io mi sono trovato nell’evoluzione del mio mestiere… piano piano… ho incorporato sempre di più questo sguardo. Poi quando uno è fotografo, continua a esserlo anche senza macchina fotografica, a guardare la realtà nello stesso modo. Piano piano mi sono avvicinato a un tipo di approccio che si può definire antropologico. Tant’è che poi alla fine mi ritrovo oggi a collaborare molto di più e molto più felicemente con antropologi, in ambito antropologico, che non con i giornali come agli inizi della mia carriera da fotografo. Probabilmente anche perché io sono evoluto in una direzione e i giornali sono evoluti in un’altra e ci siamo separati.
La fotografia non è qualche cosa di fisso, di stabile, di assolutizzante. Non è un’entità, è una relazione. […]
Il Bianco e nero per Franco Zecchin
Gli viene posta un’altra domanda: “Forse è giunto il momento che tu ci dica qualcosa sul bianco e nero. Perché io ho sempre un po’ l’impressione che nella scelta del bianco e nero non ci siano mai soltanto questioni di tipo stilistico o estetico, ma in fondo anche questioni di tipo etico. E’ così per te?”
Franco risponde: “L’etica è qualche cosa difficile da definire, quindi quando parliamo di etico bisogna vedere cosa intendiamo. Per me il bianco e nero da un lato è un tipo di linguaggio, per me, più naturale, del quale ho più dimestichezza, mi esprimo meglio. Il colore nasce più da una necessità. Ora faccio anche dei progetti di foto a colori, in cui utilizzo il colore e non il bianco e nero. Quindi c’è già un altro tipo di evoluzione. Però l’origine della mia fotografia a colori è un’origine alimentare. Dovevamo fare foto anche a colori perché i magazine e i mensile non volevano il bianco e nero o li pubblicavano molto meno facilmente che non il colore. Per poter pubblicare il bianco e nero dovevi avere veramente qualche cosa di particolare tipo ad esempio I Nomadi… o anche un riconoscimento del fatto che tu sei solo in bianco e nero, e quindi o quello o niente, ma è chiaro che ti tagli una grande fetta di mercato.”
Domanda: “Perché ti senti più a tuo agio con il bianco e nero?”
Franco: “Il bianco e nero svela l’artifizio. Noi non vediamo il mondo, le cose, in bianco e nero, quindi quando io lo mostro in bianco e nero, mostro già che c’è un’interpretazione, che c’è un qualche cosa di diverso che non la realtà com’è. E quindi anche se poi io nel mio mostrare voglio aderire a una realtà… e lì la doppia valenza della fotografia che da un lato riprende la realtà, dall’altro c’è pure lo sguardo del fotografo, quindi è un’interpretazione. Quindi questa ambivalenza può sembrare contraddittoria, può esserlo anche, però in fondo l’idea del bianco e nero per me è che in questa ricerca di essenzializzazione, essenzializzo ancora di più, nel senso che tolgo degli elementi di colore che magari non riesco a controllare o magari aumentano l’informazione contenuta nell’immagine in un modo che non mi interessa.
Fotografia e memoria
Una della cose importanti della fotografia è che l’immagine fissa si radica nella memoria in modo più forte e più immediato. La memoria, si può dire, si crea privilegiando le immagini. Se vogliamo ribaltare il ragionamento, attraverso le immagini fisse si può creare la memoria. La memoria è importante perché se noi perdiamo la memoria, cosa sono stati quegli anni in Sicilia per esempio, c’è il rischio che le cose si ripetano. E’ sempre bene mantenerla viva, questa memoria, e il modo migliore per mantenerla viva è utilizzando anche le immagini.