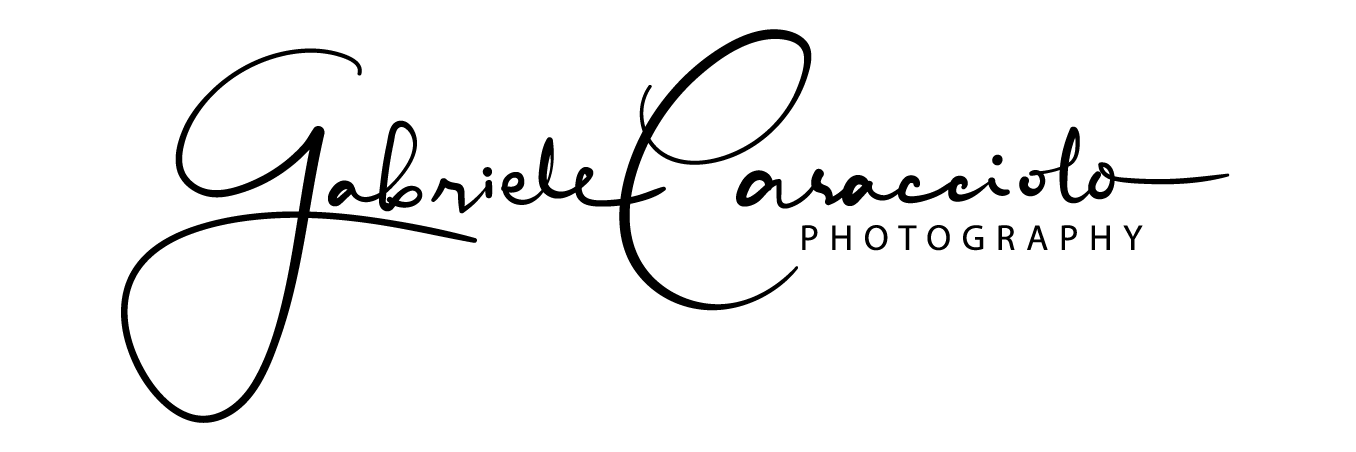Appunti di fotografia [15] – Ugo Mulas
Il bianco e nero mi interessa di più per una ragione molto elementare. Il colore sembra più falso proprio perché dal colore ci si aspetta la verità, ma sono i colori che la Kodak prepara nelle emulsioni. Il cielo diventa di quel blu che è stato messo dalla Kodak.
Col bianco e nero sai già che ti trovi di fronte ad un’astrazione. Sai già in partenza che fai una cosa che non è naturalistica perché dai equivalenti neri, bianchi, grigi, a quelli che sono poi i colori e quindi questa consapevolezza dell’artificio ti aiuta poi ad accettare il risultato.
Col bianco e nero il discorso è più ideologico, mentale. Il bianco e nero è più un mezzo, un mezzo per fare un discorso, mentre il colore diventa fine a se stesso.
Nel ritratto, l’uomo davanti e quello dietro l’obiettivo sono consapevoli di quel che avviene.
Come i bambini che non sanno ancora parlare, e quando cercano o vogliono una cosa si esprimono avvicinandosi ad essa, toccandola, o fiutandola, o indicandola con mille atteggiamenti diversi, così il fotografo, quando lavora, gira intorno all’oggetto del suo discorso, lo esamina, lo considera, lo tocca, lo sposta, ne muta la collocazione e la luce, e quando finalmente decide di impossessarsene fotografandolo, non avrà espresso che una parte del suo pensiero.
Forse per questo quando entro nello studio di un pittore, sento di dover lasciar fuori le mie idee precostituite, i miei sofismi sulla sua pittura. Posso lavorare solo sui materiali che trovo, su ciò che l’artista mi mostra, su ciò che esiste. E quando mi scordo di questo, è la macchina che mi richiama alla realtà; questo è il limite ma anche il vantaggio del fotografo rispetto al critico. Come le parole che cambiano a seconda delle persone a cui ci si rivolge, così il mio comportamento, il mio atteggiamento cambia a seconda di chi mi sta di fronte. E’ quindi evidente che il fotografare si risolve in uno studio del comportamento.
Capita, dopo poco tempo, che si dimentica quanto si deve alla macchina. Ti sembra che tutto succeda per opera tua, e finisci col chiedere all’apparecchio di trasmetterti tutto il suo potere senza preoccuparti dello scopo, purché ti garantisca il successo.
C’è un senso di immobilità nelle fotografie, fermare il gesto per sempre e prolungarlo all’infinito. E’ come se il tempo non corresse più. Una sensazione paurosa che fa pensare alla morte. Un tempo immobile, ininterrotto, che dà l’angoscia di continuare a vivere nell’immobilità assoluta.
Quando si fa il ritratto a una persona si può assumere un’infinità di atteggiamenti verso questa persona, e farle assumere un’infinità di atteggiamenti verso chi fotografa. Non c’è ritratto più ritratto di quello dove la persona si mette lì in posa, consapevole della macchina e non fa altro che posare, invece solitamente quando si dice che si vuole essere naturali non si intende essere naturali verso se stessi ma essere naturali verso la macchina, cioè verso il fotografo, come per ingannarli, dire io sono qui ma fingo di non sapere che voi ci siete, così la mia finzione sarà più credibile. Invece fotografare uno mentre fa qualcosa è registrare un fatto, quindi fare della cronaca. Il ritratto in un certo senso è qualcosa di più nobile rispetto alla fotografia di cronaca purché non ci sia nessuna reticenza, nessuna finzione verso l’operazione nel suo insieme, che deve essere la più scoperta la più diretta possibile.
Io non voglio essere legato tutto il giorno e tutta la vita a pochi attimi eccezionali. Io voglio che ogni momento della mia vita possa essere un attimo eccezionale. La verità è tutta la nostra vita, tutta la nostra giornata minuto per minuto e ogni minuto può valere l’altro e anzi deve valere l’altro, come non credo ad esempio, come non ho mai creduto, che per fare la bella fotografia sia necessario andare in Cina, in India, in Russia. Ho sempre voluto credere che nella mia stanza e nella mia casa avrei potuto fare qualsiasi ricerca fotografica di grande livello. Ciò che veramente importa non è tanto l’attimo privilegiato quanto individuare una propria realtà, dopodiché tutti gli attimi più o meno si equivalgono. Circoscritto il proprio territorio, ancora una volta potremo assistere al miracolo delle immagini che creano se stesse, perché a quel punto il fotografo deve ridurre il suo intervento alle operazioni strumentali, l’inquadratura, la messa fuoco, la scelta del tempo di posa in rapporto al diaframma, e finalmente il clic. Qui grazie all’apparecchio noi accettiamo la vita in tutta la sua realtà, quindi anche in ogni suo attimo fuggitivo. Al fotografo il compito di individuare una sua realtà, alla macchina quello di registrarla nella sua totalità.
Il tempo acquista una dimensione astratta nella fotografia, non scorre naturalmente come accade nel cinema o nella letteratura. Sullo stesso foglio nello stesso istante coesistono tempi diversi.
Tratti da: Rothko/Mulas – Rai 5, Art night, St. 2020/21, Ep. 13.